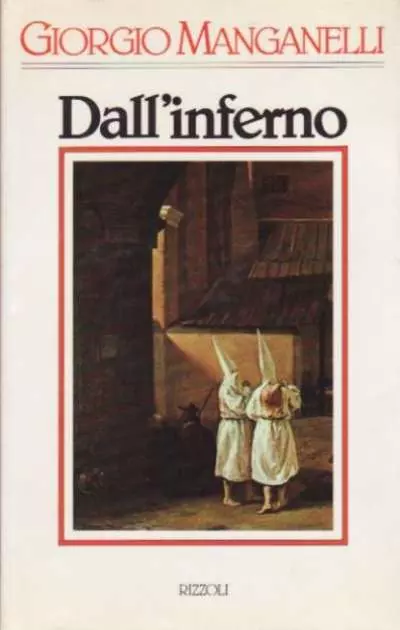Da subito cerca di definire il luogo dal quale continua a parlare e pensare, descrivendo qualcosa di plumbeo e claustrofobico, una zona pervasa di nebbia e ignara di colori e forme. All’interno di questa eternità immobile si muove fluttuando, entrando in contatto con voci e forme che transitano nella caligine. E ancora: l’apparizione orrorifica di un manichino di paglia, i dialoghi non-sense con una delle voci per definire il nebbioso empireo, fino all’incontro chiave con uno strano medico e alla rivelazione di una bambola di stoffa inserita dentro il corpo del narratore. La bambola si nutre delle sue viscere, del suo spazio interiore e defeca dentro di lui, liberandosi di una merdarella biancastra che richiama alla mente le emanazioni diafane di tante (false) fotografie spiritiche dell’800.
L’inferno del Manga è una scheggia di tenebra assurda e onirica, piena di echi disperanti, esseri malformati, roghi di streghe in un magma di putredine e carnami. Nella notturna bolgia, tra rimorti e rinascite, il romanzo (ecco, ci sono cascato!) è una sorta di metamorfosi continua, il pullulare allucinato di una scrittura fantasma e labirintica da cui non sembra esservi uscita. Nel sinistro finale, la bambola si tramuta in una bambina e il narratore riesce a gettare uno sguardo oltre la caligine, fino a scorgere su un trono vuoto un brulicare di forme minute, forse larve di angeli, agglomerati di rettili, un teschio, o il volto di qualche divinità definitiva. Si esce dalle pagine con la sensazione che tutta la paccottiglia weird di questi ultimi anni sia robetta. Manganelli, già nella metà degli anni ’80, aveva scritto di un percorso allucinato e senza direzione all’interno del corpo stesso della letteratura. E non sarà l’ultima volta. Dopo toccherà alla Palude definitiva, uscito postumo nel ’91, ultima stazione di un viaggio oltretombale. Certo Manganelli non è stato certo l’unico a gettare uno sguardo nei regni dell’aldilà. Sarebbe impossibile per chi scrive tracciarne una sintesi completa. Piero Camporesi ha raccontato meglio di altri l’inferno come un teatro di tormenti e fetore, una colonia penale sotterranea simile a un mattatoio o un ospedale; ne La casa dell’eternità racconta l’involuzione delle case del diavolo nelle parole dei predicatori seicenteschi, fino ai mutamenti del morbo dantesco in un serbatoio di fantasmi e apparizioni funeste di mondo moderno in cui flagelli e fame si attenuano.
Non voglio perdermi dentro la letteratura straniera e nemmeno spulciare scrittori troppo lontani dalla mia sensibilità contemporanea. Tuttavia non posso tralasciare il Beckett di Come è (1961). L’aldilà del Manga è sicuramente derivato da quello dello scrittore irlandese. Beckett è lontano dai virtuosismi barocchi e dalla lingua di Manganelli, tuttavia nell’aldilà beckettiano le determinazioni del tempo e dello spazio sono vaghe, anche qui il corpo del narratore è degradabile, mentre la voce continua comunque a raccontare. L’aldilà in Beckett è spesso freddo, fatto di alterazioni di colore e buio (Immaginazione morta immaginate), con il bianco come colore dominante (Bing), spazi cilindrici illuminati da luci gialle e un debole stridio d’insetti (Lo spopolatore). I cubi, le rotonde, i cilindri di questi scritti degli anni ’60 somigliano più a un Purgatorio astratto e fantastico, comunque una rappresentazione metafisica del nostro quotidiano (quadrati, tondi, parallelepipedi fanno da sfondo alle narrazioni bloccate e all’isolamento delle pitture di Francis Bacon, esseri mutilati che non raccontano più una storia, se non una fuga da sé, dal proprio corpo stravolto e deformato). Lo sfondo di Come è presenta fango, spicchi di cielo, terra e i resti di un’umanità che si trascina nell’eternità con delle scatole di tonno; altra similitudine con Manganelli è nella scatologia dei personaggi che si pisciano e defecano addosso. Il grigiore indistinto di Beckett e Manganelli, più che al teatro dei tormenti infernali, fa pensare a un Purgatorio, un limbo non lontano da quello descritto dall’Alighieri. L’immagine dantesca descrive una montagna agli antipodi di Gerusalemme, un dolce cielo, un paesaggio attraversato da salmodie, canti e preghiere, popolato di angeli luminosi e anime percorse da profondo pentimento e gentilezza di cuore. Tuttavia il Purgatorio è attraversato da un’aura indefinibile e sospesa, le figure umane dei defunti si muovono in gruppi, come pecorelle smarrite il cui cammino è incerto e solitario.
Saltando di palo in frasca mi viene in mente il romanzo postumo di Guido Morselli Dissipatio H.G., anche qui racconto di un aspirante suicida (non è chiaro se riesca nel suo intento) che si ritrova proiettato in un mondo fatto di strade, piazze vuote, ordinate e tranquille. Un evento inspiegabile ha sorpreso la gente nel sonno, li ha rapiti lasciandosi dietro scatole vuote, biglietti usati, auto in fila, un dissolvimento nel nulla; in uno dei finali più belli della letteratura contemporanea, ciò che resta al protagonista senza nome è una lotta impalpabile con il vuoto affollato, con la tensione e la noia di un aldilà in cui non c’è altro che inscenare una kermesse di manichini femminili, bagnanti con mattoncini ai piedi che galleggiano e si raggruppano nelle acque perplesse di una piscina comunale. Per vie diverse si muoveva anche il primo Parise, quello de I movimenti remoti (1948), visionaria descrizione di un uomo chiuso nella propria tomba, una voce onnisciente e immobile sospesa tra la vita e il nulla e in mezzo il fantasma di una scrittura onirica che non disdegna citazioni dal Leopardi del Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (ma Leopardi, non a caso, è molto amato anche da Manganelli). Lo spazio narrativo del romanzetto di Goffredo Parise è riempito dalla voce allusiva del narratore, presa in un’indagine sonora dei suoni che provengono dall’esterno, le voci e i rumori di una vita che sbatte ovattata contro lo zinco della bara, oppure barlumi di ricordi, monologhi surreali e la nostalgia carnale del sesso. Come sarà col Manga, il viaggiatore oltretombale di Parise è solo una scrittura allucinata prigioniera nella caliginosa urna della pagina.
In quegli imprecisati anni ’80 anche Tiziano Sclavi racconta di un narratore ucciso fin dalle prime pagine della Circolazione del sangue; comincia un viaggio psicanalitico nei suoi ricordi infantili, traumi di una vita sullo sfondo di una Milano abitata da terroristi, vicini molesti, teppisti e l’ombra del Mostro di Firenze. Edoardo Sanguineti, col Giuoco dell’Oca, parte dall’ennesimo narratore cadavere chiuso in una bara in compagnia di svariati oggetti. Anche Federico Fellini ci lascia scritto col suo G. Mastorna la visione dell’altro mondo: piazze vastissime, autombulanze, chierici, caroselli di hostess, elicotteri, stazioni, metropolitane, città modernissime, distese paludose, chiese di tutti i culti e voci di imbonitori. L’aldilà di Fellini è affollato di speranze, gente frettolosa e indaffarata come nella vita di tutti i giorni e con un brusio di binari, controllori e locomotive. Dino Buzzati nel ’69 pubblica un divertissement pop come Poema a fumetti, riprendendo stimoli dal G. Mastorna e popolando un aldilà fatto di strade, vie, donne nude, cappotti parlanti, diavoli e militari in una sarabanda caotica e rumorosa. Recentemente scrittori come Andrea Gentile e Antonio Moresco hanno messo in scena la loro visione narrativa di un oltretomba; Moresco in particolare nei Canto di d’Arco mescola con originalità thriller metafisico e noir descrivendo un mondo dei morti speculare a quello dei vivi, un posto fatto di grattacieli, svincoli e sopraelevate, centri commerciali e torri che si spingono più in alto nel cielo; il mondo dei vivi è in comunicazione con quello dei trapassati, tanto che i poliziotti vivi chiedono l’aiuto ai loro omologhi morti per sgominare una rete di pedofili e assassini.
La suggestione potrebbe portarmi lontano: leggendo l'articolo Mariupol oggi, dopo un anno di guerra, si descrive l’angosciosa situazione della cittadina ucraina, le file di ore intorno ai palazzi marci per una ciotola di riso, coi russi che bruciano le biblioteche e i libri per distruggere sistematicamente ciò che rimane della Ucraina; le cliniche e gli ospedali riempiti di soldati russi che tornano mutilati dal fronte in Donbas e i cittadini di Mariupol che si aggirano come esuli, incapaci di fidarsi di nessuno perché potrebbe essere una spia. Gli stupri, come malattie e saccheggi, sono all’ordine del giorno, così come epidemie e infezioni. Mariupol è una città selvaggia in cui chi sopravvive è un fantasma a cui non rimane altro che guardare la Tv di Mosca mentre racconta l’ucronia di un mondo nuovo. Marco Belpoliti, parlando di un’altra apocalisse quotidiana, quella di Ground zero, aveva descritto un luogo informe di macerie, polvere e detriti, di camion che furtivi la notte portavano via come novelli monatti i rottami d’acciaio e i corpi che vi erano sbriciolati dentro… Basta con queste suggestioni! Torno da dove sono partito e chiudo. Manganelli! Il Manga e la sua palude postuma del ‘91.
Diciamo che fin qui, la maggior parte degli scrittori menzionati ha messo in scena un aldilà (infero o purgatoriale che sia, o anche solo un limbo bloccato e mal digerito dove il morto non si decide a varcare né l’una né l’altra dimensione) che è sostanzialmente sovrapponibile al nostro; la cosa non deve esser letta come mancanza d’ingegno, tutt’altro! Credo che i nostri letterati volessero suggerirci che l’altro mondo, gli inferi son già questi e non dobbiamo arrovellarci troppo. Manganelli invece ha scelto una strada differente, poco praticata da noi, una strada che lo ricollega a Beckett. La palude se vogliamo estremizza e semplifica la visione del Manga: si comincia col solito narratore disincarnato e senza nome che non ha già più memoria (vaghi e sfuggenti ricordi) del suo passato; le prime righe somigliano a certi stati onirici del Lovecraft, con frammenti visivi di sontuose città ed edifici irti di pinnacoli; il narratore rammenta di esser stato processato (una farsa stregonesca con tanto di boia e folla in cagnesco degna di un gotico) per qualche colpa di cui è all’oscuro, condannato a un esilio, espulso a cavallo; comincia un breve tragitto che lo conduce in un’altra città piena di tagliagole e falsari, dove incontra un vecchio che nasconde il viso nell’ombra di una lucerna; qui sente per la prima volta parlare della palude, non luogo in cui nessun giustiziere oserebbe mai infilarsi, postribolo definitivo per chi ha compiuto gesti tali da essere abbandonato dagli dèi e dagli uomini; il narratore sente subito che la palude sarà la sua meta definitiva, la cerca e la trova con facilità, penetrando così in una distesa instabile e piana d’un grigio bavoso, acqua, canne, giunchi e terra fradicia; e qui il Manga si trova nel suo e sfodera la sua lingua impareggiabile descrivendo le minuzie di quei liquami, il sommesso crepitio e il viscido scorrere di animali minuscoli dove tutto striscia, sibila, copula, nasce, defeca. L’avanzamento della storia è minimale: il narratore trova una casa nella palude e qui vi alloggia per il resto del romanzo (?), stando seduto su una sedia posta davanti a una finestra che si affaccia sulla distesa brulicante; all’osservazione alterna lo studio di alcune carte di cui ignora l’alfabeto o uno stato onirico e notturno in cui la palude pare mutar forma e trasformarsi.
Come sempre in Manganelli la seconda parte del romanzo diventa difficile e impenetrabile, un flusso di pensieri che si accavallano, col dubbio che la palude altro non sia che un immane cimitero di morti o un inferno svuotato dove le punizioni e il giudizio si sono estinti per macerazione. Tra epifanie del pensiero e allucinazioni notturne le pagine finali implodono sulla casa nella palude e le sue fluide trasformazioni, con la sensazione che sia la casa a muoversi verso una luminescenza sinistra, promessa di un diarca, di qualche divinità o del nulla vertiginoso1. E potrei finire così, senonché leggo il Discorso sull’aldilà della prosa di Celati e mi accorgo che dentro ci sono già molti degli scrittori che qui ho raccolto: Gianni Celati parla principalmente di Leopardi e, riferendosi a un pensiero dello Zibaldone, scrive, “che l’aldilà delle parole diventa la cosa più importante: l’aldilà dei voli immaginativi, delle fantasie non costruttive, del “piacer vano delle illusioni”. Diventa la linea astratta d’una prosa che non è più consacrata alla rappresentazione del mondo, ma piuttosto al suo dissolvimento: al dissolvimento d’ogni volontà di rappresentazione storica o psicologica”. E anche queste righe basterebbero a farci capire molto della Palude e del Manga. Ma Celati che ha già tutto chiaro nella testa scorge subito le analogie tra il Manga e il Leo, “verso un aldilà del mondo, che è poi aldilà delle parole; e l’aldilà delle parole, come l’aldilà della morte, è una cosa che non si può verificare, né conoscere”. Basta? No, perché ancora sul Manga dice: “le discese agli inferi di Manganelli sono altrettanto errabonde e senza meta; forse perché gli inferi, o gli altri aldilà delle parole, possono essere visitati solo a tentoni, alla cieca, seguendo la danza delle frasi che spuntano sulla pagina. Dante aveva il suo cammino tracciato, nell’aldilà: noi no”. E con questo chiudo, dedicando questo scritto al ricordo di Gianni Celati.
- Andrea Cortellessa nelle sue piccole monografie manganelliane dice qualcosa che potrebbe aiutarci a intravedere qualcosa dietro ai simboli oscuri di questi finali: parlando di Landolfi che parla di Cechov (ma anche tirando in ballo Borges) ci dice che dietro le pagine o i simboli del labirinto si cela il volto dell’autore, la sua immagine; ed è forse questo il cuore rivelatore, non una trama raccontabile, bensì uno strato sotterraneo e segreto dell’anima che ne costituisce la grandezza.