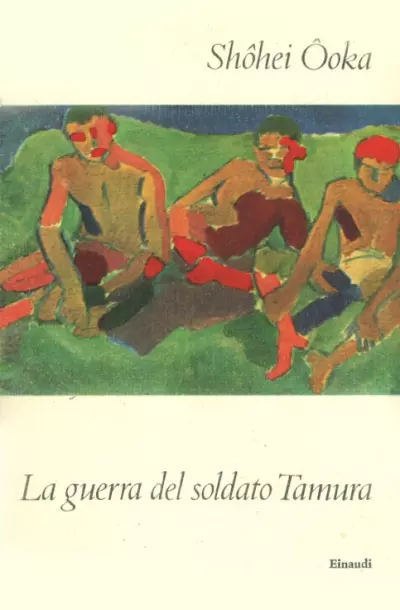Il romanzo è del 1951 e merita ammirazione la scelta di Einaudi di proporre nel 1957 un libro così scioccante, con una traduzione dall'originale giapponese (che tristezza le traduzioni di traduzioni inglesi proposte oggi troppo spesso! questa versione di Giuseppe Morichini è luminosa, finissima, anche se vorrei saperne di più sulla parola tradotta "Dio"). La scelta dell'immagine di André Derain in copertina, con le macchie rosso vivo a enfatizzare alcune parti del corpo ‒ gambe, mani, teste, volti ‒ suggerisce, con un inconsueto movimento dal simbolico al letterale, le mutilazioni di guerra descritte nel libro. Quanto al titolo, sicuramente l'originale sarebbe stato più pregnante, anche se meno esplicativo: i "fuochi nella pianura", infatti, sono un elemento chiave. Il loro fascino ipnotico, incantato, è presente all'inizio della storia, richiamato a metà e svelato solo alla fine nella sua importanza.
La studiata ricorrenza del tema dei fuochi è un esempio dell'armonia strutturale del romanzo: i brevi capitoletti sono concatenati da una logica sotterranea che a una prima lettura passa inosservata; a una rilettura meditata, la fatalità della sequenza emerge con violenza, anche se non con univocità (i titoli, delle stilettate: Pensieri paradisiaci, Apparizione, L'affamato e il pazzo, I gigli dei campi, La carne, La razza umana, La scimmia, solo per citarne alcuni). Perfezione strutturale, concettuale e formale: ogni parola gioca una funzione estetica ed espressiva in una ricerca di realismo spirituale che sta tra Oriente (la disarmonia come male, l'affermazione di sé come atto di violenza contro l'ordine cosmico, la ciclicità come senso del vivere) e Occidente (l'attrazione per il cristianesimo, i significati cristologici dell'offerta delle proprie carni da mangiare). Di spirito occidentale Shôhei Ôoka era imbevuto: era un esperto di letteratura francese con la passione per Stendhal, tanto che scrisse un adattamento giapponese de Il rosso e il nero (Le signore della pianura di Musashi), e attraverso le parole di Tamura (ovvero se stesso, che combatté nelle Filippine come il suo personaggio) manifesta la sua avversione per la filosofia di Bergson e il concetto di perenne progressione della vita.
Siamo verso la fine della Seconda guerra mondiale: nelle Filippine la situazione dell'esercito giapponese, costretto a fronteggiare gli attacchi degli americani da un lato e la guerriglia della resistenza locale dall'altro, è disperata. Il soldato di prima classe Tamura viene scacciato dal suo plotone perché tubercolotico. Anche all'ospedale lo rifiutano e si ritrova così a ingrossare le file dei reietti che tirano a campare per strada. Tra loro incontra due bizzarri personaggi, il giovane Nagamatsu, afflitto dal beri-beri, e il vecchio Yasuda, reso zoppo da una piaga tropicale. Il giovane è figlio illegittimo di un signore e di una serva; il vecchio è padre di un figlio illegittimo nato da una serva. Tra i due si instaura un rapporto malato che inizia con toni da commedia sentimentale e che si concluderà in tragedia cosmica e apocalittica sconfitta del genere umano. Il peggior nemico si rivela subito la fame, peggiore delle bombe, delle malattie, degli agguati, delle insostenibili condizioni climatiche. La fame è il motore che innesca la vicenda, il filo rosso che ne segna il tragitto, la chiave che apre la porta della trasformazione finale.
Ma è il movimento – nello spazio, nel tempo, nello spirito – che domina la vicenda di Tamura e cattura il lettore in lentissime, avvolgenti spire, suscitando un senso di spaesamento ma anche di infinita dolcezza, in forte contrasto con la crudezza della storia. E ciò accade nonostante vengano forniti continui e dettagliati riferimenti spaziali e temporali, che il protagonista si sforza di riferire con precisione, soffermandosi sui percorsi, sulla toponomastica locale, sulla descrizione dei luoghi, sulla ricostruzione delle ore e dei giorni che trascorrono.
Il paesaggio stesso si muove. Dalla nave che lo trasporta per la prima volta verso le isole, lo scenario delle Filippine appare a Tamura stranamente disciplinato: uniforme, immutato, esso si sposta assecondando il movimento regolare della nave, e in questa meccanica regolarità vi è un presagio di morte, non temibile ma profondamente "naturale", appunto. Il mestiere del soldato, che porta a guardare a ogni irregolarità e buca del terreno, a ogni albero, a ogni altura come ad aspetti da sfruttare per le proprie necessità, oltraggia il valore divino del paesaggio naturale.
La trasformazione del paesaggio accompagna, rispecchiandola, quella del protagonista: se al principio delle peregrinazioni di Tamura la natura appare rigogliosa, apre il cuore ed eccita il senso di libertà, impercettibilmente essa trascolora in un Eden che offre spontaneamente i suoi frutti (e se di Eden si tratta, di certo seguirà una cacciata). Progressivamente il paesaggio si umanizza, si modella sui pensieri del personaggio che lo osserva, e le curve delle colline ricordano seni e fianchi di donne mollemente stese, gli alberi particolari anatomici e gesti delle donne del suo passato, con un ulteriore movimento dal fuori al dentro che prelude al crollo successivo: è in qualche modo oltraggioso anche piegare il corso della natura alla propria interiorità.
La rottura dell'armonia è segnata da tre momenti consecutivi: la visione dei cadaveri-cose, che solo nello sforzo di una minuziosa descrizione (grondante strazio, sangue, poesia) assumono finalmente, a distanza di tempo, una consistenza reale; la visita alla chiesa cristiana, dalla cui croce visibile in lontananza Tamura era stato attratto; l'uccisione senza motivo, ma volontaria, di una donna filippina. Da questo momento in poi il paesaggio prima tace, poi osserva con mille occhi, minaccioso, infine guarda benevolo...
Il rovesciamento tra guardare ed essere guardati avvia la trasformazione definitiva di Tamura: unto del Signore? Angelo vendicatore? Folle? Impressionante finale, tra Il riso rosso di Leonid Andreev e L'Aldilà di Lucio Fulci.