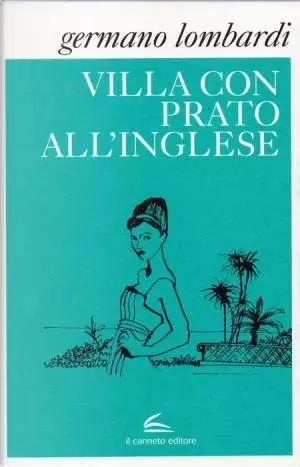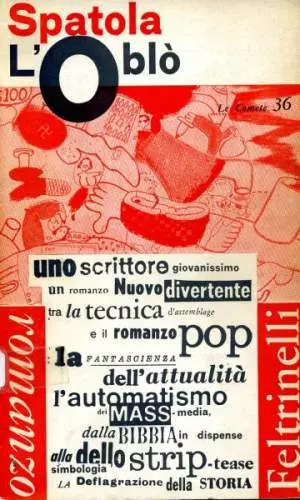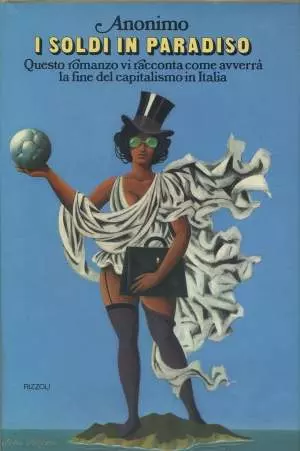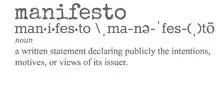Il romanzo di Germano Lombardi pretende (e illude) di essere un romanzo oggettivo. Ha un luogo - la riviera ligure nei pressi di Imperia - un tempo - il 20 febbraio 1977 - personaggi descritti minuziosamente - in primis un ispettore privato di nome Nuvolo Cisterna e un floricoltore, Omérus Macaulay Jonesco - e un mistero - "fatti insensati e vandalismi in apparenza senza scopo accaduti nella villa dell'ingegner Volt", la villa con prato all'inglese che dà il titolo all'opera. Il lettore accorto che abbia tra le mani la versione originale Rizzoli del 1977 o la ristampa del 2012 de Il Canneto Editore, si accorgerebbe con una certa facilità che la pretesa ossessiva di descrivere ogni particolare reale non è altro che una maschera, un espediente.
Avvicinarsi oggi alla letteratura sperimentale che si praticava più di cinquant’anni fa significa fare un salto in un grande altrove impraticato, persino ostile, un corpus anti-narrativo lasciato cadere nell’oblio. Scelgo di prendere il sentiero di questa selva intricata passando non a caso per L’Oblò di Adriano Spatola, pubblicato da Feltrinelli nell’ottobre del 1964 nella collana sperimentale Le Comete n. 36.
Il Paese dei mostri: commedia all'italiana e letteratura sperimentale di massa tra gli anni ’60 e ‘70
Davide RossoNel settembre del 1975 l’editore Rizzoli manda in libreria un interessante volume a firma di Anonimo, I soldi in paradiso. Si tratta di un racconto fantapolitico, una commedia sulla fine del capitalismo in Italia e sul tracollo di un intero sistema politico. Il romanzo tiene conto del senso di fine di una collettività e delle mutazioni di un certo italiano inetto e fanfarone alla base di molti film della commedia degli anni ’60, in particolare quelli interpretati da Alberto Sordi. Gli anni ’70 tuttavia sono l’ultima stagione di popolarità del nostro cinema, un decennio fecondo e sperimentale, d’irripetibile libertà.